Dopo averle trascurate o addirittura negate, per lungo tempo, le questioni della crisi climatica e dell’insostenibilità dell’attuale paradigma produttivo e di consumo sono rientrati con forza nelle agende politiche globali nell’ultimo ventennio e, per quanto alcuni ancora continuino a trattarli con superficialità, oggi vediamo i risultati dell’atteggiamento negazionista, portato avanti dagli anni ‘ 70 agli anni 2000, e iniziamo a pagarne le conseguenze.
La produzione ha un ruolo molto importante rispetto a questi problemi, che, spesso, si è provato a minimizzare giustificando la sovrapproduzione e presentandola come una necessità del genere umano, senza la quale ci saremmo ritrovati senza le nostre comodità, catapultati in una sorta di Medio Evo senza i beni prodotti in quantità da queste aziende. L’approccio produttivo tenuto finora, infatti, è mirato soprattutto al produrre il più possibile senza mai domandarsi se quello che si produce, e come lo si produce, sia sostenibile o meno, un approccio il cui unico obiettivo è l’allargare il proprio mercato in una prospettiva senza limiti temporali o di risorse disponibili. Una visione spiccatamente antropocentrica, unita all’individualismo capitalistico, che ci ha allontanato dalla percezione dell’essere umano come parte di un ecosistema senza il quale l’essere umano non può esistere. Una visione aberrata che ci ha spinto tutti a guardare solo verso quello che si poteva prendere, per stare meglio, per essere più ricchi, fino a sovra-sfruttare l’ecosistema stesso che si è ridotto, in questo tipo di percezione, ad un semplice fornitore di materie prime e accumulatore di rifiuti. Le aziende, fino a pochi decenni fa, non hanno mai pensato, a meno di pochi casi, che quello che stavano facendo non avrebbe assicurato la sopravvivenza alle generazioni future, negando qualsiasi implicazione ambientale e pensando solo al proprio benessere.
Nonostante alcuni designer, nel passato, si siano esposti professando una estraneità del Design rispetto ai problemi di inquinamento e sovrapproduzione presenti nel mondo (Ettore Sottsass negli anni ’90 affermava che: “Deve preoccuparsi dell’ecologia chi fa le navi da guerra e usa tonnellate d’acciaio. Non lo vengano a dire a me che faccio una maniglia ogni cinque anni!”), anche loro non possono dirsi senza colpa a riguardo. Nonostante i buoni propositi che hanno dato inizio a questa disciplina, di fatto il design si è assoggettato o è stato manipolato da questi meccanismi di produzione e di mercato e si è dimenticato del suo fondamentale ruolo sociale. I designer si sono lasciati abbagliare dal successo, nella maggior parte dei casi, e non si sono più chiesti cosa stessero facendo e per quale scopo, limitandosi a produrre più cose possibile, sfornando tutti i progetti richiesti dalle aziende.
Dalla metà degli anni ’80 ad oggi i mercati sono stati inondati da prodotti spinti da una forte comunicazione che ha distratto, sia i consumatori che i designer, dalle tematiche realmente importanti, per portare tutto il peso del progetto sullo styling, progettando prodotti che diventassero status symbol, stimolando il ricambio dei prodotti all’estremo e inculcando, nella mente di tutti noi, l’erronea convinzione che “siamo ciò che possediamo” e, per rimanere sempre sulla cresta dell’onda, ci siamo sentiti in obbligo di aggiornare sempre i nostri oggetti feticcio, altrimenti saremmo usciti dal giro che conta (anche in questo caso non facciamo di tutta l’erba un fascio, ma parliamo comunque della maggioranza dei casi).

Conscio del fatto che il modo migliore per non inquinare è non produrre nulla, ma essendo stato sempre lontano da approcci così radicali, mi sono chiesto tante volte nei miei venti anni di professione cosa potesse fare al riguardo il Design (il fatto che io scriva Design con la maiuscola o con la minuscola non è un errore, bensì è un modo per distinguere due approcci differenti alla progettazione: uno egocentrico e poco attento alle questioni sociali (design) e uno che fa diventare il progetto un elemento di cultura e si impegna ad avere, anche in minima parte, una attenzione alla società (Design).) e in questo capitolo andremo ad indagare quelle (ancora) poche risposte che ho trovato, lasciando tanto spazio alle domande a cui bisogna iniziare a dare una risposta o, quantomeno, far scaturire un dibattito a riguardo. Per farlo, però, dobbiamo prima di tutto definire il significato di “sostenibilità”.
Questa parola, oggi usata tantissimo e a volte abusata, spesso viene fraintesa. Infatti la definizione di “sostenibilità” è molto più complessa di quello che può sembrare e, di solito, la si riduce al solo aspetto ambientale o, addirittura, si pensa che essere sostenibili sia tornare a vivere nella natura cercando di avere il minimo impatto possibile sull’ecosistema. Per quanto trovi quest’ultima visione molto affascinante (anche se so bene che non saprei mai rinunciare a tutte le comodità che abbiamo acquisito nel corso dei secoli, come molti di voi, e forse non sopravvivrei per più di qualche mese), la sostenibilità non è questo.
Se provate a cercare la definizione di questa parola su un dizionario (se siete della mia generazione) o su un motore di ricerca, quello che viene fuori è che per sostenibile si intende una condizione di sviluppo che sia capace di assicurare il soddisfacimento dei bisogni di questa generazione ma senza compromettere la possibilità, per le prossime generazioni, di soddisfare i propri.

Questo concetto ha iniziato a farsi strada nelle alte sfere politiche solo 50 anni fa, nel 1972, grazie ad una importante ricerca voluta dal gruppo denominato “Club di Roma” e portata avanti al MIT da un giovane gruppo di ricercatori, capitanati da Dennis L. Meadows.

Andiamo per ordine. Il Club di Roma era, allora, quello che oggi chiameremmo un think-tank, cioè un gruppo di importanti pensatori che si occupavano di capire dove stesse andando il mondo e cosa si sarebbe dovuto e potuto fare per far sì che il futuro potesse essere il migliore possibile. Fondato nel 1968, grazie soprattutto al carisma e alla volontà di un personaggio estremamente intelligente e visionario, Aurelio Peccei, il Club di Roma interpellò, allo scopo di avere risposte su come si evolverà il mondo alla luce dei ritmi di crescita che si stavano delineando, il System Dynamic Group del Massachusetts Institute of Technology, guidato da uno dei fondatori della dinamica dei sistemi ed esperto di computer, Jay Forrester. La dinamica dei sistemi, la teoria dei sistemi complessi e i computer erano solo all’inizio del loro percorso, ma Peccei e gli altri credettero da subito importante poter usare queste nuove tecnologie e teorie per avere una visione obiettiva a lungo termine sul futuro dell’umanità. La necessità di questa visione nasceva dalla presa di coscienza, da parte dei componenti del Club di Roma, di una incapacità delle classi politiche di guardare al mondo come un unicum, come ad un sistema, e, quindi, di poter affrontare le problematiche globali che si andavano delineando per il futuro. Nell’introduzione alla pubblicazione della ricerca lo stesso Peccei dice:
“Senza una forte ventata di opinione pubblica mondiale, alimentata a sua volta dai segmenti più creativi della società – i giovani e l’”intellighenzia” artistica, intellettuale, scientifica, manageriale – la classe politica continuerà in ogni paese a restare in ritardo sui tempi, prigioniera del corto termine e d’interessi settoriali o locali, e le istituzioni politiche, già attualmente sclerotiche, inadeguate e nonostante ciò tendenti a perpetuarsi, finiranno per soccombere. Ciò renderà inevitabile il momento rivoluzionario come unica soluzione per la trasformazione della società umana, affinché essa riprenda un assetto di equilibrio interno ed esterno atto ad assicurarne la sopravvivenza in base alle nuove realtà che gli uomini stessi hanno creato nel loro mondo”.
Una dichiarazione di necessità del coinvolgimento globale che era ed è ancora assolutamente fondata e attuale ma che fu utilizzata, dai sottrattori, come deterrente, accusando il Club di Roma di voler instaurare una sorta di oligarchia capace di controllare il mondo intero. Questo fu uno dei tanti modi perpetuati allo scopo di derubricare questa importante ricerca e attaccare quelli che l’avevano voluta e redatta, a dimostrazione di quanto sia difficile per l’essere umano accettare un cambiamento così radicale, anche quando questo sarebbe assolutamente necessario. Oggi, nonostante la maggiore sensibilità sul tema, la situazione non è molto migliorata.
Ma come era strutturata e cosa diceva la ricerca del MIT?
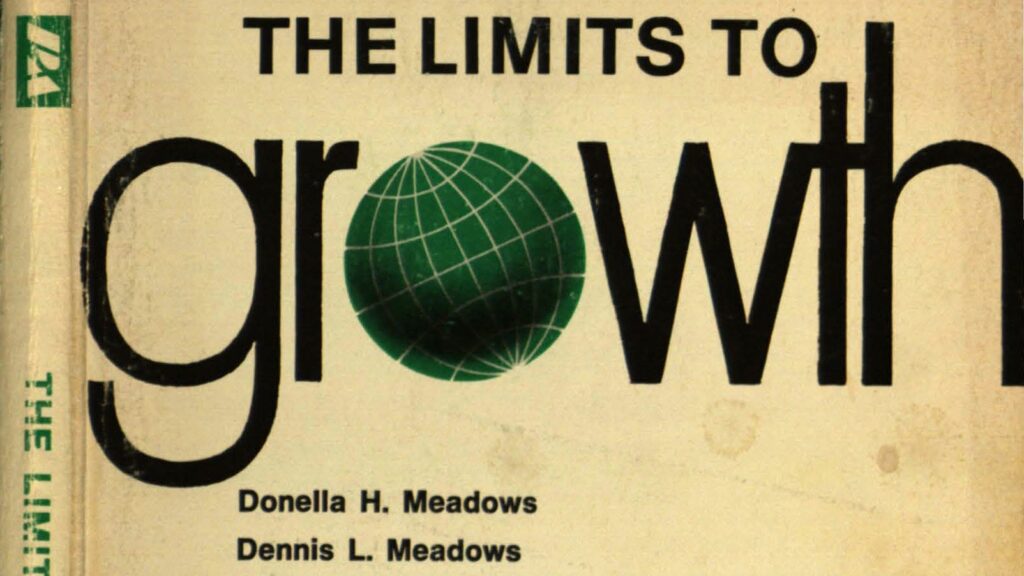
Il compito assegnato ai ricercatori fu quello di studiare, rispetto al contesto mondiale, l’interdipendenza e le interazioni di cinque fattori critici: l’aumento della popolazione, la produzione di alimenti, l’industrializzazione, l’esaurimento delle risorse naturali e l’inquinamento. Il processo di analisi venne sviluppato attraverso un modello che teneva conto di questi cinque fattori e delle relazioni, positive e negative, tra questi, arrivando a definire una dozzina di scenari diversi attuabili attraverso le scelte politiche, produttive e di salvaguardia ambientale che si sarebbero messe in campo. Lo scopo, naturalmente, non era quello di dare una soluzione e voler decidere del destino dell’umanità da un pulpito (come molti detrattori ebbero a dire), bensì di far iniziare una discussione seria e fattiva su questi temi. Nel testo della ricerca (The limits to growth, D.H. Meadows, D.L. Meadows, J.Randers, W.W. Behrens III, Potomac Associates, 1972), infatti, molte volte i redattori (in particolare Donella H. Meadows, moglie di Dennis L. Meadows e principale redattrice del report) chiariscono che i dati sarebbero da approfondire, che lo sviluppo tecnologico potrebbe far variare molti parametri e che c’è un ampio spazio di critica (costruttiva, naturalmente) rispetto agli scenari prefigurati, manifestando una volontà di azione agonistica di questo elaborato.
Nell’ottica di raggiungere un livello sostenibile di sviluppo, un elemento venuto fuori dalla ricerca del MIT e su cui mi sembra il caso di soffermarmi è una particolare attenzione ai prodotti, al prolungamento della loro vita mediante una accurata progettazione, capace di facilitare le riparazioni e allontanarne l’obsolescenza. Un elemento, dunque, molto vicino alla produzione e al Design che si sarebbe dovuto tenere molto in considerazione. L’obiettivo del Club di Roma, e dei ricercatori coinvolti, era, al di là di questo, semplicemente portare alla luce un problema e metterlo sui tavoli politici internazionali, in modo che ci fosse occasione per poterlo affrontare dal giusto punto di vista, quello globale, e nei giusti tempi – vista la caratteristica inerzia dei sistemi complessi e dell’ambiente in particolare. Di certo non possiamo dire che da allora (50 anni fa) si sia fatto moltissimo, però il loro obiettivo principale fu centrato. Infatti proprio quell’anno, il 5 giugno 1972, ci fu la prima conferenza ONU sull’ambiente, una conferenza che pose le sue basi proprio su questa ricerca e iniziò a definire quello che oggi chiamiamo “sviluppo sostenibile” – definizione che fu poi perfezionata fino ad arrivare a quella del 1987, contenuta nel rapporto Brubdtland.
Rispetto alla definizione generica di sostenibilità, il concetto di sviluppo sostenibile aggiunge la necessità di un equilibrio degli sforzi, a livello locale e globale, per poter soddisfare i bisogni fondamentali dell’uomo, senza danneggiare o distruggere l’ambiente. Allo scopo di definire le relazioni tra i tre pilastri della sostenibilità – ambiente, società ed economia – si elaborò una rappresentazione in cerchi nidificati dei tre pilastri, in cui l’economia è inserita all’interno della società ed entrambe sono racchiuse nel cerchio dell’ambiente, rappresentando, in questo modo, il fatto che ogni elemento (o pilastro) è un sottosistema di un altro e l’aumento di uno dei sottosistemi implica la riduzione di quello che lo contiene.

Iniziamo a riflettere, dunque, sul fatto che la sostenibilità non riguarda solo l’ambiente, che è, comunque, l’insieme più grande che comprende il resto, ma anche la società e l’economia, elementi che permettono all’essere umano di vivere in pace e con il benessere necessario. Tutti e tre gli elementi sono assolutamente necessari affinché si possa parlare di uno sviluppo sostenibile. Spesso, infatti, il concetto di sviluppo sostenibile viene rappresentato con un diagramma di Venn in cui i tre pilastri diventano tre circonferenze che si intersecano, identificando tre sovrapposizioni tra due dei tre pilastri e una sola area in cui tutti e tre i pilastri sono intersecati. Le sovrapposizioni tra due elementi identificano azioni di vivibilità, eque e realizzabili, ma solo l’area comune a tutti e tre i pilastri identifica ciò che può essere definito sostenibile. Negli ultimi anni, a seguito dei dibattiti che si sono generati intorno al tema della sostenibilità, i temi si sono ampliati arrivando ai così detti “circles of sustainability” che contengono quattro pilastri principali: la sostenibilità economica, ecologica, politica e culturale, ponendo l’attenzione proprio sul tema culturale e sulle diversità che hanno fatto, da sempre, la ricchezza del genere umano.
Come si è mosso e come si sta muovendo il Design a riguardo?

Partiamo da un presupposto: trovo alquanto anacronistico che in molti centri di formazione al Design esistano ancora corsi di Eco-Design o di Design per la Sostenibilità, in quanto, oggi, una definizione di questo tipo è una contraddizione in termini. Definire che esista un Eco-Design o un Design Sostenibile implica, infatti, che possa ancora esistere un Design non sostenibile e questo credo che sia difficilmente accettabile da chiunque. Il Design, oggi, deve essere sempre mirato alla sostenibilità, con tutte le difficoltà concettuali e produttive che questo approccio porta ancora, ma, nonostante queste, non possiamo esimerci dall’avere sempre e comunque un occhio attento allo sviluppo sostenibile e, di conseguenza, alla questione ambientale, economica e sociale che ruota intorno ad ogni singolo prodotto nuovo che viene progettato.
Detto questo, il tema della sostenibilità del Design è stato trattato molto e da autorevoli autori, i quali hanno dato ottime indicazioni su come potersi muovere con attenzione in questo ambito. Naturalmente le indicazioni sono ben differenti dalle soluzioni, non solo perché è obiettivamente impossibile trovare delle soluzioni sulla sostenibilità che valgano, contemporaneamente, per tutto quello che riguarda il Design, ma soprattutto per quella complessità e interdisciplinarietà della progettazione e quella fluidità dell’approccio progettuale caratteristici di questa disciplina.
Uno dei libri che hanno guidato il mio approccio alla sostenibilità fin dall’inizio della mia esperienza è certamente “In the bubble – Design per un futuro sostenibile” di John Thackara.

Pubblicato nel 2005, l’autore di questo libro, partendo proprio dalla definizione di sostenibilità, ci impone una riflessione sul ruolo del progettista nel determinare l’impatto ambientale che avrà l’oggetto o il servizio che sta progettando. Una delle frasi di apertura del libro recita, infatti: “L’ottanta per cento dell’impatto ambientale esercitato dai prodotti, dai servizi e dalle infrastrutture attorno a noi viene determinato allo stadio progettuale”, sottolineando dunque la responsabilità del designer nelle singole scelte che prende e, in automatico, dando a quest’ultimo un ruolo molto importante nella salvaguardia dell’ecosistema. Questa responsabilità Thackara la estende a tutto il genere umano in quanto “il fare umano è in sé un progettare” e quindi ci accompagna in una analisi, da diversi punti di vista, di quello che succede oggi (dal 2005 non è cambiato molto) e cerca di indicare nuove direzioni al lettore. L’approccio è, anche in questo caso, quello proprio dell’agonismo e, quindi, di capitolo in capitolo, ci mette di fronte a crude verità, fastidiose, per poi ipotizzare percorsi futuri.
Un approccio molto stimolante, soprattutto perché non si impone un modo di progettare al designer, non gli si dice: “si fa così!”, ma si ragiona, mi verrebbe da dire “insieme”, su quali potrebbero essere delle soluzioni più sostenibili dello stesso problema e dà ai designer un ruolo di promotori di cambiamenti. Questo di promuovere il cambiamento, come è facilmente intuibile, è un tema che riguarda la capacità di comunicare dei prodotti e il Socio Design di Burckhardt, ed è anche trattato da altri autori come, ad esempio, Paolo Tamborrini nel suo libro “Design sostenibile – oggetti, sistemi e comportamenti” (Electa, 2009), in cui dice: “Il designer è chiamato quindi, oltre a concepire oggetti sostenibili, a indurre comportamenti sostenibili all’interno di rinnovati scenari di vita”.

L’approccio concettuale di Thackara a riguardo del Design è basato sulla presa di coscienza della enorme quantità di energia e, di conseguenza, di anidride carbonica e rifiuti che costa ogni singolo oggetto o servizio che utilizziamo. A partire dal fatto che per produrre un PC si producono rifiuti pari a quattromila volte il suo peso, fino alla quantità di anidride carbonica emessa da un singolo viaggio aereo che equivale a quella emessa in un anno da un cittadino qualunque, da tenere presenti sono quegli enormi flussi di materiali ed energia che vengono sfruttati per produrre, trasportare, usare e dismettere qualsiasi oggetto, quella che, in gergo, viene definita embergy (embedded energy) e che definisce la reale, e purtroppo non percepita, impronta di quell’oggetto sull’ecosistema.
Questa presa di coscienza lo porta a farci riflettere sulla possibilità di sostituire il possesso con l’uso degli oggetti, di progettare sistemi più che prodotti e di mettere meglio a sistema quello che già abbiamo a disposizione invece di continuare a produrre. Una visione sicuramente condivisibile che però presuppone sempre un cambio culturale necessario a riguardo, una sensibilizzazione delle persone che deve essere un obiettivo primario affinché, successivamente, si possano applicare nuovi paradigmi, nuovi scenari di vita. Tamborrini, nel suo libro, ha proprio questo tipo di approccio. Conscio del fatto che non è sufficiente progettare soluzioni mirate, ci fa capire quanto sia necessario, invece, progettare scenari futuri e ripensare la cultura del progetto. Una cultura progettuale che sposta il suo target e passa dall’assioma tradizionale dell’inquinare meno a quello ben più complesso dello stimolare una nuova consapevolezza ambientale nella società.
L’approccio di Tamborrini pone le sue basi sull’indagare “il dibattito intorno al ruolo del Design nello sviluppo sostenibile”. Questo punto di partenza permette all’autore di interrogarsi non solo sul prodotto della progettazione – cosa che avrebbe limitato il suo excursus ad un elenco di oggetti sostenibili – bensì apre l’opportunità di indagare cosa può fare il Design per la società affinché questa abbia un approccio più sostenibile, in tutto quello che fa. Una apertura del possibile campo di azione del Design che, di nuovo, va al di là dell’oggetto in sé riguardando anche tutto quello che l’oggetto genera intorno a sé, in termini di riflessioni, sensibilità e, soprattutto, comportamenti, combaciando con l’idea del designer come promotore di cambiamenti di Thackara. Questo stesso pensiero era condiviso anche da altri grandi autori e designer come Maldonado, Dorfles, Munari. Il designer Victor Papanek sosteneva che il ruolo del progettista fosse un ruolo di responsabilità nel proporre le trasformazioni necessarie alla società, insomma una responsabilità che è sempre stata chiara dall’inizio della storia del Design e di cui, evidentemente, tutti ci eravamo un po’ dimenticati, sopraffatti dalla produzione, dal mercato e dal benessere misurato in termini di produzione. Tamborrini ne fa una questione etica, giustamente, e gli dedica un intero capitolo nel suo libro. Esponendosi in maniera diretta e chiara, come ogni designer dovrebbe imparare a fare, definisce la necessità di guardare in faccia alla complessità della realtà e a quei fattori che impediscono alla massa di sviluppare un sentimento ecologico, in primis con una critica al consumismo che ci ha reso incapaci di percepire la ricaduta, in termini di materia ed energia sempre, dei nostri comportamenti.
Questo è il punto centrale di ogni discussione sulla sostenibilità: sensibilizzare le persone, renderle coscienti del danno che provocano quando non hanno comportamenti sostenibili. Raggiungere questo obiettivo, però, non è affatto semplice perché le persone non amano cambiare le loro abitudini, soprattutto se il cambiamento è troppo rapido. Un risultato più efficace lo si ottiene solo formando le persone al cambiamento, un processo molto più lungo, ed è proprio questa la funzione del Design: mettere in discussione lo status quo e proporre nuovi scenari, attraverso il linguaggio che gli è proprio, il linguaggio degli oggetti.

Questo sgabello è fatto con uno dei principali rifiuti organici al mondo: gli scarti del caffè.
Formare il consumatore significa fargli avere un ruolo attivo nella definizione del mercato. Un consumatore che diventa, così, un prosumer e chiede che i prodotti siano più sostenibili, etici, equi e solidali, ed è capace di scegliere il prodotto attraverso propri criteri e indirizzare il mercato verso un nuovo scenario. Questo è un processo culturale che, una volta instaurato, non ci farà più percepire la scelta di un prodotto ecosostenibile come una costrizione morale, ma faremo quella scelta perché quel prodotto risulterà rappresentativo della persona che lo acquista e lo farà riconoscere come parte integrante di una società, con quegli stessi interessi culturali ed espressivi e, come dice Tamborrini: “il designer dovrà quindi lavorare sull’elaborazione di scenari di interesse per i fruitori, costruendo quel substrato culturale che determina la categoria dell’attraente e del giusto, per far sì che il consumatore arrivi a pensare «compro ciò che protegge l’ambiente e questo fa parte del bello»”.
Naturalmente è chiaramente necessario, per questa evoluzione culturale, l’appoggio della politica e delle amministrazioni, locali e globali, che per prime devono essere sensibilizzate ad un nuovo paradigma possibile che, per esempio, passi dall’avere il PIL come indicatore di benessere a valutare, più coerentemente, il benessere sulla qualità della vita, dell’ambiente, dell’istruzione, dei servizi e via dicendo, un benessere non materiale dunque che valuti più la qualità dei “prodotti umani” e dell’ambiente più che le quantità di prodotti che ogni anno immettiamo nel sistema.
Proprio la questione “qualità vs quantità” ci permette di parlare anche di un altro tipo di approccio al Design che si fa sempre più strada nel dibattito contemporaneo: Il Design Sistemico.
Lo schema di produzione che abbiamo applicato fino ad oggi, nella maggior parte dei casi, deriva dalla linea di produzione fordista ed è quello che viene definito, appunto, un sistema di produzione lineare. In questo sistema all’inizio della linea fanno il loro ingresso le risorse necessarie alla produzione che vengono lavorate nella linea di produzione per farne uscire i prodotti. Chiaramente, insieme ai prodotti escono dalla linea di produzione tutti gli scarti che si sono generati nella fase di lavorazione, i quali vanno a finire nell’ambiente sotto forma di anidride carbonica o altri inquinanti. Le materie prime utilizzate nella produzione, inoltre, arrivano spesso da molto lontano, impiegando una notevole quantità di energia, sfruttando risorse finite e generando molto inquinamento. L’embergy di questo tipo di produzione, come si può facilmente dedurre da queste poche indicazioni, è molto alta. Se a questo aggiungiamo il processo di delocalizzazione di diverse lavorazioni in parti del mondo in cui conviene economicamente farle – non considerando il peso insostenibile che questo tipo di approccio ha sull’ambiente, sulle società, sulle culture e sulle economie planetarie – evidentemente ci rendiamo conto di quanto tutto questo sia inaccettabile.

A questo sistema produttivo, negli ultimi anni, si sta contrapponendo un nuovo sistema definito “circolare” che prevede l’uso di risorse vicine e, più specificamente, cerca il modo di trasformare gli output (scarti) delle lavorazioni di un’azienda in input (materie prime) per un’altra produzione. Molta attenzione, dunque, è data al flusso di materia ed energia che attraversa questo sistema, fino a rivalutare quelli che fino a pochi anni fa erano considerati solo rifiuti ed oggi diventano risorse. Inoltre l’approccio seguito in questo tipo di sistema ha il plus valore di attivare dei processi locali di relazioni che si ripercuotono sulla società con effetti estremamente positivi.

Nel suo libro (Design sistemico – Progettare la sostenibilità produttiva e ambientale, Luigi Bistagnino, Slow Food Editore, 2009), Luigi Bistagnino ci introduce a questo nuovo paradigma produttivo mostrando le tante caratteristiche sostenibili di un simile approccio, tutte scaturite dal considerare la produzione non come un evento isolato e avulso dal contesto, ma come parte di un sistema più ampio che si relaziona e interagisce con altri eventi produttivi, permettendoci di sfruttare elementi di scarto che passano dall’essere un costo per l’azienda al diventare una risorsa vendibile e che, in più, stimola un circolo virtuoso e sostenibile, in un processo sociale, economico e ambientale che determina un sistema autopoietico molto simile a quello naturale.
Questo concetto di mimesi della natura è stato già utilizzato come riferimento da Gunter Pauli nella sua ricerca intitolata “Blue Economy – Nuovo rapporto al Club di Roma”, in cui, criticando l’approccio “green” come troppo complesso e costoso da applicare, sviluppa e propone diverse prospettive di nuovi prodotti derivanti dall’osservazione della natura, facili da produrre e capaci di usare al meglio le biodiversità presenti sul pianeta generando, di conseguenza, lavoro e ricchezza in ambito locale e, di conseguenza, globale.
Quello del Design Sistemico, insomma, è un nuovo approccio al design che propone una sorta di “design umanistico” e non “edonistico” (così lo definisce Bistagnino) che parta dall’osservazione della natura per poter attuare una mimesis tecnologica e trasferire le cose osservate nella produzione, in modo da ottenere una circolarità la più simile possibile a quella dei processi naturali e che non preveda rifiuti bensì, in un sistema compiuto, questi diventino materie prime per attuare una ulteriore produzione e così via. Una visione molto stimolante che mette in discussione, oltre alla struttura lineare della produzione attuale, anche il paradigma della globalizzazione, la quale sta sempre più mostrando i propri lati oscuri, fatti si sfruttamento delle risorse naturali e umane, di appiattimento culturale e di aumento del divario tra paesi poveri e paesi ricchi.
Per questo motivo molti economisti e studiosi stanno iniziando a sviluppare nuovi concetti e paradigmi che siano capaci di essere sostenibili. Uno di questi è sintetizzato bene dal termine “glocalizzazione”. Questo termine, portato alla ribalta da Zygmund Bauman, è usato per sottolineare alcune lacune lasciate dalla globalizzazione e più precisamente per puntualizzare l’importanza delle culture locali nello sviluppo delle nostre società ed evitare il depauperamento culturale che il sistema globalizzato sta producendo in diverse regioni del mondo, a seguito del quale perderemmo grandi risorse in termini di conoscenza e di diversità. Una presa di coscienza che ha spinto molti verso un’analisi più chiara degli effetti della globalizzazione sulle società e sul fatto che la globalizzazione, come tutti gli strumenti a disposizione dell’uomo, ha lati positivi e lati negativi. Se l’approccio al sistema globale non dimentica i quattro pilastri della sostenibilità allora si potranno sviluppare nuovi prodotti su base locale e con sistemi circolari e sostenibili che poi potranno essere comunicati a livello globale e, di conseguenza, saranno strumenti di sensibilizzazione che dimostrino la possibilità di attuare processi diversi ma che assicurano, comunque, uno sviluppo sostenibile alle comunità coinvolte.

Chiaro è che questo approccio preveda un iter progettuale più aperto e non focalizzato solo sul prodotto in sé ma che abbia una visione più ampia e che sia capace, prima di iniziare a parlare di prodotto, di guardare ai luoghi e alle opportunità produttive degli stessi per poterne sfruttare le caratteristiche intrinseche nel modo migliore. Una sorta di meta-progetto che si struttura in un’analisi che necessita di diverse professionalità capaci di interagire in ottica progettuale in maniera tale da mettere a sistema l’esistente e, da questo sistema, far scaturire i prodotti di questa meta-progettazione.
Insomma il Design, come stiamo vedendo, aumenta sempre più di complessità e questo non deve essere percepito come una difficoltà ma come una opportunità di collaborazione che stimoli un approccio interdisciplinare alla progettazione. L‘interdisciplinarietà del Design è cosa nota da tempo ormai e, ad oggi, il confrontarsi con il sistema complesso che ci accoglie rende sempre più palese la necessità di un confronto che oggi manca e che deve assolutamente tornare in cima alla lista dei nostri pensieri. L’aver focalizzato la nostra attenzione sul prodotto, insomma, credendo che una persona o poche persone potessero risolvere la questione del Design senza troppi problemi, ci ha allontanato dalla visione ampia del sistema in cui ogni prodotto è immerso, da quello che ogni prodotto genera intorno a sé e da come il prodotto interagisce col comportamento umano e con l’ambiente.
Dal 1972 sono passati 50 anni, la possibilità di agire nell’ambito del Design c’era e fu resa palese proprio dalla mostra al MoMA di New York, la questione del consumismo, dell’inquinamento e il conflitto interiore dei giovani designer sarebbero potuti essere il motore di questo processo per affrontare il problema ambientale e della sostenibilità nell’ambito del Design. Cosa sia successo non è facile definirlo, le dinamiche in questi casi hanno percorsi difficili da intercettare e spesso ci si limita ad esprimere una opinione personale che, per quanto interessante possa essere, è solo la deduzione di un singolo da un solo punto di vista. La possibilità c’era e forse dovremmo solo capire quali erano gli elementi che hanno creato quel giusto substrato culturale che ha permesso la nascita di questo germoglio e non pensare troppo a quello che poi è stato, ma provare a ricreare quell’ambiente di confronto e di scontro, di antagonismo e di ricerca, per poter avere ancora un’altra opportunità di poter affrontare la questione della sostenibilità dal punto di vista progettuale. Come disse Peccei e come poi hanno affermato altri grandi autori (The rise of the creative class, Richard Florida, Basic, 2002), è tempo che una nuova classe di creativi – designer, ingegneri, sociologi, scienziati, ecc. – prenda in mano questi temi e inizi a prefigurare uno scenario futuro sostenibile, cercando di coinvolgere le più alte sfere della politica affinché si facciano i giusti passi in quella direzione.
Articolo di Angelo Bucci






